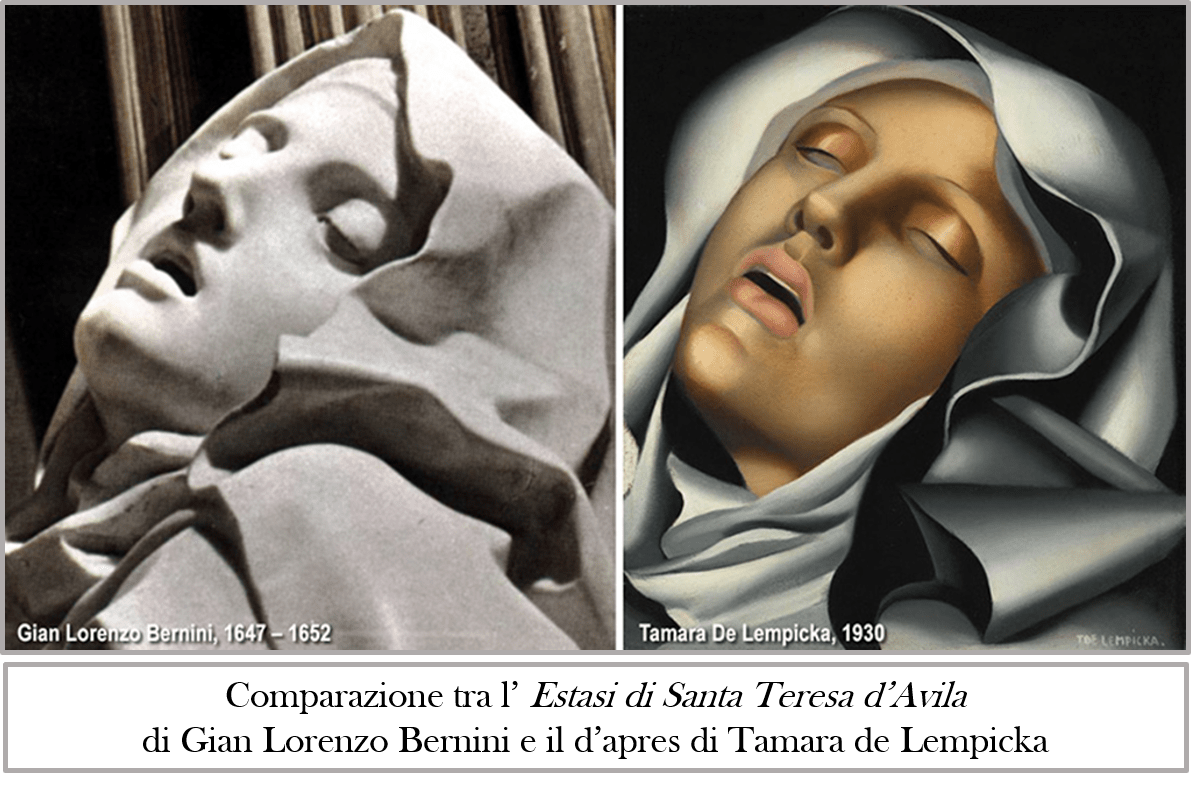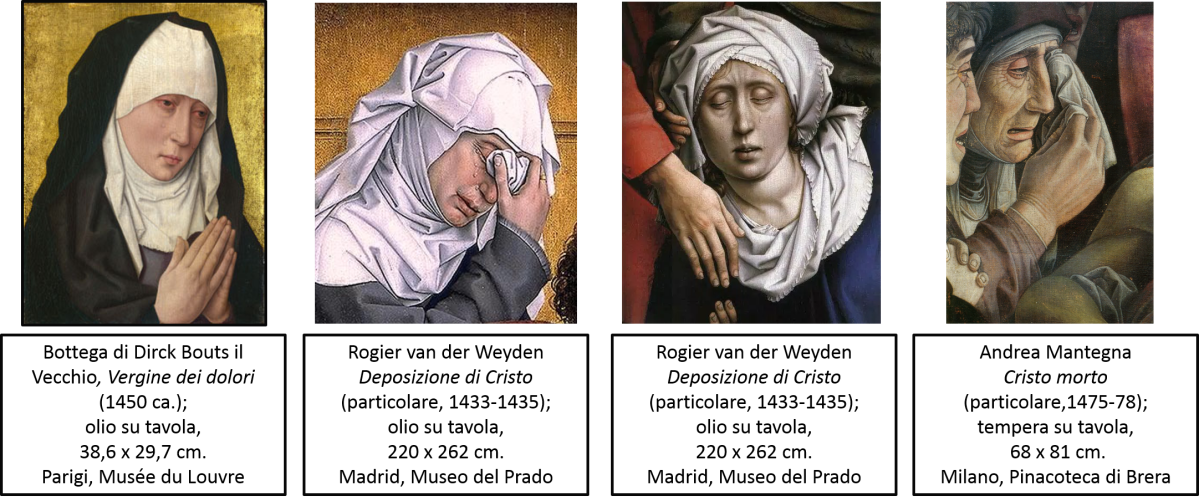GUCCIONE – IUDICE, TRA DESIDERIUM ET DILIGENTIA.
PIERO GUCCIONE. “IL MARE DENTRO”
(PARTE PRIMA)
di Filippo Musumeci
Sabbia a perdita d’occhio, tra le ultime colline e il mare – il mare – nell’aria fredda di un pomeriggio quasi passato, e benedetto dal vento che sempre soffia da nord.
La spiaggia. E il mare.
Potrebbe essere la perfezione – immagine per occhi divini – mondo che accade e basta, il muto esistere di acqua e terra, opera finita ed esatta, verità – verità – ma ancora una volta è il salvifico granello dell’uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso, un’inezia che basta da sola a sospendere tutto il grande apparato di inesorabile verità, una cosa da nulla, ma piantata nella sabbia, impercettibile strappo nella superficie di quella santa icona, minuscola eccezione posatasi sulla perfezione della spiaggia sterminata. A vederlo da lontano non sarebbe che un punto nero: nel nulla, il niente di un uomo e di un cavalletto da pittore.
- Thomas: È uno specchio, questo mare. Qui, nel suo ventre, ho visto me stesso. Ho visto davvero. (Alessandro Baricco, “Oceano mare”, 2007)
 Lì, lungo quel lembo di terra baciato dalle onde; lì, in quell’infinita distesa azzurra, resa mobile dal vento di scirocco e vestita dal sole di vibranti dorature, due maestri danno vita al canto del mare. Sì, al canto! Perché è melodioso suono quello che trasuda la tela vestita di morbidi pigmenti che si danno alla luce come messi a nudo, come due amanti nell’unione dell’amplesso. E cos’altro se no! Piero Guccione e Giovanni Iudice: non certo i primi, eppure, credo, pochi sono riusciti ad assorbire e racchiudere nel quadro l’elemento “mare” al pari dei due maestri siciliani. Ciascuno a suo modo, ma, tesi tra evasione e immersione, tracciano una scia come la prua di una barca laggiù, persa all’orizzonte come un sentimento gelosamente taciuto.
Lì, lungo quel lembo di terra baciato dalle onde; lì, in quell’infinita distesa azzurra, resa mobile dal vento di scirocco e vestita dal sole di vibranti dorature, due maestri danno vita al canto del mare. Sì, al canto! Perché è melodioso suono quello che trasuda la tela vestita di morbidi pigmenti che si danno alla luce come messi a nudo, come due amanti nell’unione dell’amplesso. E cos’altro se no! Piero Guccione e Giovanni Iudice: non certo i primi, eppure, credo, pochi sono riusciti ad assorbire e racchiudere nel quadro l’elemento “mare” al pari dei due maestri siciliani. Ciascuno a suo modo, ma, tesi tra evasione e immersione, tracciano una scia come la prua di una barca laggiù, persa all’orizzonte come un sentimento gelosamente taciuto.

Li amo entrambi, passionalmente, come parti di un’unica matrice; ne seguo le sorti discretamente come un amante per la cortese amata. Non saprei preferirne l’uno all’altro, ecco! Compirei un sacrilegio impossibile da esorcizzare, rinnegherei ciò che mi fu gratuitamente elargito in termini di ritrovata “libertà”. “Libertà” di sguardo e spirito, di fiato e d’infinito. Nella produzione figurativa dei due pittori, le marine sono uno dei molteplici campi esplorati, non il solo esclusivo, e come gli altri soggetti indagati esso nasce da inclinazioni interiori che da estemporanee tendenze estetiche.
Avere l’ambizione di ricostruire l’intera opera di Guccione e Iudice è un’impresa titanica di cui non intendo in alcun modo investirmi, almeno in codesta sede (magari un domani, chissà!), non solo per la vastità del loro corpus figurativo, ma per un limite oggettivo di battute, credo improponibile per un blog. Tuttavia, questo vuole essere un sincero omaggio a due grandi uomini fra i più rappresentativi dell’arte post-moderna e dei quali si vuole presentare la personalissima visione circa l’approccio al tema del “mare”, dinanzi alla cui magniloquenza non si può che esser trasparenti.
Friedrich scriveva: «Chiudi il tuo occhio fisico, al fine di vedere il tuo quadro con l’occhio dello spirito. In seguito, dai alla luce ciò che hai visto durante la notte affinché la sua azione si eserciti di rimando sugli altri esseri dall’esterno verso l’interno». Sia Guccione che Iudice hanno saputo guardare e tradurre il loro mondo, così vicino e lontano allo stesso tempo, con gli occhi dello spirito, giungendo, infine, a soluzioni diverse perché diversa è la loro interiorità e diverso il loro vivere nel mondo.

Guccione è il pioniere di una nuova figuratività, l’amico di Renato Guttuso, il fondatore del Gruppo di Scicli, l’anziano maestro rimasto fanciullo con “il mare dentro”; Iudice, anche lui pioniere di una nuova visibilità, l’uomo che mi fregia di esserne sinceramente amico, l’artista che non fa “gruppo” perché la solitudine gli è necessaria come urgenza di verità, il maestro divenuto presto adulto e “dentro il mare”. Distanza e vicinanza, esterno e interno, impalpabile e tattile si equivalgono e completano come cielo e mare, giustapposti appena da quella sottile linea orizzontale che non ne segna affatto la fine, bensì solo il punto di partenza. Le vedute marine di Guccione rappresentano una costante ricerca concepita sul finire degli anni Sessanta e ancora in evoluzione per via di quell’eterno inappagamento dello stesso per il percorso fin qui tracciato. Sono, in realtà, la vivida trasfigurazione di un mare respirato, indagato, sognato, melanconicamente solitario e silenzioso perché depurato dal corrosivo agire dell’uomo, e ove ogni bieco fine non lascia di sé alcun solco.

Un rifugio incontaminato, atemporale, come esplicito omaggio allo spirito romantico di sapore nordico di Friedrich – io vi ho sempre visto anche tanto di Turner –, un rigore geometrico verso la fissità della visione come in Cézanne (vertice d’ispirazione della sua maniera), una fuga espressionista come terapia esistenziale in Edvard Munch; un’eterna attesa senza tempo come nelle distese oceaniche di Edward Hopper, un’intensa pulsione verso la felicità oltre il tormento come nei lavori dell’amico Francis Bacon e di cui Guccione dirà: «A me piace molto che egli abbia detto che la bocca del papa avrebbe voluto dipingerla come un tramonto di Monet. Si capisce perché parli con ammirazione di Monet. Ci sono anche in Bacon le grandi campiture di colore, ed in quelle campiture un’intesa felicità».


Ancora affermerà: «Ebbi un colpo di fulmine per Friedrich, non so perché. Poi ho scoperto quanto Munch venisse da Friedrich. Erano per me quadri di natura che avevano una fragranza e la verità che in essi determinava il senso dell’ora e del tempo, ma erano anche quadri profondamente soggettivati. E tuttavia senza l’intenzione di fare il bel quadro. Quello di Friedrich era un occhio freddo e incandescente assieme».
Il passo riportato è significativo del forte ascendente esercitato dalla pittura dell’artista di Greifswald su quella dell’artista siciliano fin dal 1977, anno della mostra parigina del primo ammirata dal secondo, nonché causa diretta dei celebri d’après “Viandante che guarda il mare da Friedrich” (1982-83; pastello su carta, 65 x 50 cm. Collezione privata), “Le bianche scogliere di Rügen, da Friedrich” (1983, pastello. Collezione privata), “Le età dell’uomo III, da Friedrich”, 1983; tecnica mista, 50 x 64 cm. Collezione privata), “Le nebbie di Friedrich” (2007; pastello, 15,5 x 23 cm. Collezione privata).






Nel “Viandante” la cortina di nebbia da cui emergono le vette montuose del Kaiserkrone in Sassonia è sostituita da una piatta e calda distesa del Mediterraneo, in calce al quale Guccione annota una massima dello stesso Friedrich: «Il pittore non deve soltanto dipingere ciò che vede davanti a sé, ma anche ciò che vede in sé. Se però non vede nulla, tralasci pure di dipingere ciò che vede davanti a sé». Nel suo omaggio, Guccione permette al viandante di integrarsi con il paesaggio all’orizzonte liricamente trasfigurato, verso cui guarda e i cui caldi toni degli azzurri e dei gialli alludono alle insenature di quella spiaggia ragusano ove ora sosta, in un eterno scambio tra il vicino del piano comprensibile e il lontano del fondo, ormai, irraggiungibile. E come in Friedrich, anche qui è continua vibrazione di superficie, benché non sia semplice citazionismo, quanto, piuttosto, il fedele tentativo di superare il puro naturalismo della tradizione per sconfinare, come ricorda Andrea Guastella «nella vastità del cosmo, nella solitudine dell’uomo, nel miracolo in quieto e perturbante di un sogno illuminato» (“Lontananza di Guccione”, 2015).

Nel 1830 Friedrich ricordava come: «il compito dell’artista non è la rappresentazione fedele dell’aria, dell’acqua, delle rocce, degli alberi. La sua anima e la sua sensibilità devono rispecchiarsi nella sua opera. Il compito di un ‘opera d’arte è di riconoscere lo spirito della natura, comprenderlo, registrarlo e renderlo con tutto il cuore e il sentimento». Nella stessa misura, il cuore e il sentimento sono la chiave per comprendere la poetica guccioniana sul ruolo dell’artista e sul rapporto di questi con la natura. Un ritorno ancestrale all’amata Itaca, dopo un lungo peregrinare formativo, di questo “Ulisse sciclitano”, che riapproda alla natura natia e ivi dimora, assorto in una lenta contemplazione onirica di quel paesaggio, sono sue parole, «guardato e goduto nell’infanzia», lo stesso in cui, chissà quante volte, vi nuotava fanciullo in compagnia dei genitori nelle calde giornate estive. Carl Gustav Carus, allievo di Friedrich, scrisse che: «Chi contempla la meravigliosa armonia di un paesaggio reale, diviene consapevole della propria piccolezza e sente che in ogni cosa è partecipe del Divino: si perde allora in quell’infinito, rinunciando in un certo senso alla propria esistenza individuale. Annullarsi in tal modo non è distruggersi: è potenziarsi. Quanto normalmente è possibile concepire soltanto attraverso lo spirito, si rivela allora quasi naturalmente all’occhio fisico, il quale coglie appieno l’unità dell’universo infinito».
Ma qual è il pensiero di Guccione circa l’infinito? Egli stesso lo indica: «L’infinito ha una connotazione diversa dall’eternità perché è qualcosa di misurabile poeticamente, esteticamente, sentimentalmente. Non è una possibilità di misura reale, ma poetica sì».

Una distesa azzurrognolo-violacea ovattata che tende alla monocromia seppur intrisa di sfumature delicatamente variegate, come se l’infinito potesse esprimersi nell’unità a lui più congeniale anziché nella varietà più convenzionale. L’azzurro si fonde col cielo in una ritrovata ampiezza spaziale, ove le esile onde, da queste germogliate, si trasfigurano in cadenzate e solitarie sonorità incise dalla risacca. Queste emettono il loro primo gemito vitale all’orizzonte, che l’occhio languido e sognante scruta navigando tra indeterminate e calde sfumature intrise di riflessi, rifrazioni, rimandi: carezzevole moto che dalla natura giunge all’anima e da questa ancora all’infinito. È un abisso, dunque, dalla profondità velata di cui non si fa sfoggio alcuno del suo fondale sabbioso e di cui non se ne percepisce il moto sotto la sua piatta superficie. In questa, i soli punti di orientamento sono ridotti a poche linee dall’andamento spezzato, quale traccia di un passaggio compiuto e distante, eppure già depositaria di un’eco antica, carezzevole come il molle respiro delle sue increspature.

In un’altra sua riflessione confesserà: «Il mare? Cerco di farlo muovere per incontrare il cielo. Ma il senso del cielo è quello dell’immobilità, mentre il mare è la mobilità. Il mare è la fissità mobile, il cielo la fissità assoluta. Inconsciamente mi adopero per farli incontrare».

A tal proposito, Elena Pontiggia dirà: «Quando Guccione dipinge il cielo e il mare dipinge due cose: la prima è il cielo e il mare, la seconda è tutto il resto».
Il mare di Guccione si presenta agli occhi del fruitore nella sua inoffensiva evidenza: non turba i sensi, non si teme di esserne travolti e trascinati alla deriva, di esserne risucchiati e dimenticati. Una silente quiete di rassegnato disincanto o, ancor più, di ritrovato equilibrio, regna sovrana e persino “il naufragar mi è dolce in questo mare”. Un rinvigorito sentimento del “sublime” per cui “l’orrore” ha ceduto il posto al “dilettevole”, in un affresco corale ove una possibile sinistra minaccia è, almeno per il momento, reclusa. Dunque, una profondità spaziale estesa, una distanza prospettica verso l’orizzonte lontano come evasione dal piano, come celebrata catarsi, poiché per il pittore: «dare forma, dare spazio, è dare vita alla meraviglia del mondo».
E la sua pittura, per la quale l’amico Guttuso parlò nel 1965 di «un concreto lavoro alla cui base è il bisogno di partire dalle cose», darà davvero forma, spazio e vita alla meraviglia del creato, ma tale nobile causa implicava un distacco dalla “cosa” amata. Era necessario che Guccione lasciasse il borgo natio, che viaggiasse e dimorasse altrove, che vivesse le frenesie e le mode della Città Eterna in quel soggiorno lungo ventisette anni e, soprattutto, che provasse nostalgia per i luoghi vissuti nell’infanzia e adolescenza, quando il genio era ancora in erba; che tutto ciò divenisse “melanconia” nella sua accezione etimologica di “bile nera”, di acuta tristezza per quanto lasciatosi alle spalle.
Per Guccione: «La malinconia non può esserci estranea, perché in fondo è uno dei sentimenti che accompagna in maniera non violenta la nostra vita. Perciò è un sentimento da privilegiare. La malinconia è importante».
Era dovuto l’abbandono di quell’amore, ora distante, che lo ripensasse con quello “sguardo da lontano” così consimile a quello dei tanti figli illustri di una terra fertile e ostile, complice e rivale, madre e adultera. Il ritorno in patria alla fine degli anni Settanta è documentato da una produzione spasmodica, che per il pittore vale come «l’unica valida testimonianza che si può dare della mia vita».

È il 1968-69 quando fa edificare l’abitazione di Punta Corvo sulla costa tra Sampieri e Cava d’Aliga (poi lasciata negli anni ’80 per la nuova residenza di Contrada Quartarella nella campagna ragusana tra Scicli e Modica), da cui la riscoperta dell’azzurro, ove «ha ritrovato in quel sentimento di aria e di luce mediterraneo il baluginio della fata Morgana della poesia» (Enzo Siciliano, 1971).


Ma non un miraggio, bensì una nuova e concreta forma di bellezza progressivamente ritrovata spiegando appena, come un sipario, le ante della finestra e lo sguardo perduto in quella desolata immensità mobile. Ed è già il quadro nella sua stilizzata essenzialità: il muro di cinta di Punta di Corvo come base del dipinto, l’orizzonte come punto di fuga, le linee del mare come direttrice, l’azzurro come spazio. C’è tutto e non occorre altro! E quando c’è dell’altro, come plastica e tralicci di alta tensione, questo è il soverchio storicizzato che avanza e deturpa inesorabilmente la poesia.


Alberto Moravia dirà che: «Guccione si è messo fuori dalla storia, si è tenuto alla passione che è di tutti i temi e di tutti i luoghi e di quello soltanto».
Quel pittore, che nella Capitale riuscì a farsi strada nell’affollato panorama artistico, suscitando le lusinghiere attenzione della critica contemporanea, ma che visse pure anni di «paralizzante timidezza che mi portavo dentro e che non mi facilitava la vita», ritrova nell’isola il suo azzurro e questi ritrova il suo autore, stavolta riuniti in un sodalizio perfetto; ed è lo stesso azzurro a permettergli la riscoperta della lirica sospensione di Friedrich, in un accordo, come ricorda, «fra esterno ed interno, fra espressione ed impressione». Una riscoperta che ne comporta di conseguenza un’altra, ovvero Munch, poiché la visione guccioniana è, in effetti, più vicina di quanto una superficiale lettura possa far credere a quella munchiana, al punto da spingere nel 1973 il pittore sciclitano a compiere un viaggio a Oslo e ripercorrere i luoghi cari al maestro norvegese. Se da una parte, dunque, lo spirito romantico si mostra in tutta la sua chiarezza nella scelta del soggetto e nell’evanescenza sentimentale che ne consegue, dall’altra, invece, il germe espressionista s’insidia nel trattamento della materia filamentosa e rarefatta, quanto nel moto emotivo che dall’interno scuote e trasfigura l’esterno. Per Guccione, come per Iudice e per chi come loro è artista di “forme” oltre che di “contenuto”, vale la massima di Munch: «Io non dipingo ciò che vedo. Ma ciò che ho visto», perché, continua, la «Natura è lo sconfinato eterno regno che nutre l’arte. Natura è non solamente quel che agli occhi è visibile. Natura è le più profonde immagini della mente. Le immagini sul risvolto interno degli occhi».

Concludendo la questione attorno alla modernità di Friedrich e agli influssi esercitati su artisti posteri, da qualche tempo sostengo che se un’opera fosse capace di sintetizzare il pensiero di Guccione – e prima ancora dei vari Turner, Gericault, Frederic Edwin Church, Martin Johnson Heade, Winslow Homer, Courbet, Cézanne, Seurat, Signac, Van Gogh, Gauguin, Félix Vallotton, Munch, Matisse, Emil Nolde, De Chirico, Magritte, Dalì, Hopper, i contemporanei Franco Sarnari e Franco Polizzi (amici di vecchia di Guccione) e lo stesso Iudice, oltre, ovviamente, ad altri ancora – attorno al tema della natura e ai suoi diversificati sviluppi, credo, a mio modesto dire, che “Monaco in riva al mare” (1808, olio su tela, 98 x 128 cm. Berlino, Alte Nationalgalerie, di cui, come succitato, Guccione realizzò un d’après nel 1983, potrebbe esserne la summa, E ciò perché mi piace pensare (forse lo è davvero) che l’atteggiamento di muta contemplazione del monaco fissato dal pittore tedesco sia il medesimo vissuto nei meandri dell’animo dagli stessi artisti succitati, quale emblema della solitudine umana dinanzi a ciò che non si potrà mai domare. Ma ognuno di noi è, in fondo, quel monaco posto di tergo sulla spiaggia, muto e solitario in quell’intimo soliloquio in cui sono racchiuse le domande, sovente prive di risposte, sul segreto della nostra esistenza.
È stato detto più volte della distanza di Guccione dalla maniera di Monet; distanza che, a mio dire, può essere accettata limitatamente alla tecnica e al metodo compositivo en plein air, a cui il pittore siciliano preferisce, senza riserva alcuna, quello in atelier.

In realtà, la presunta distanza assume i toni di una vicinanza di intenti circa il dialogo diretto instaurato con la natura nel processo di rarefazione dell’immagine. Basti pensare alla celeberrima “Impression, Soleil levant” (1872-73) o ai cicli monettiani della “Scogliera della Manneporte a Etretat” (anni ’60 e ’80 dell’Ottocento), di “Argenteuil” (1872-78), degli “Scogli di Belle-Ile – La costa selvaggia” (1886-91), del “Parlamento di Londra” (1900-04), di “Venezia, il Canal Grande” (1908) e, ovviamente, quello più celebre delle “Ninfee” (1899 – 1926) per intuire come la predisposizione a una visione evanescente dall’indeterminatezza spaziale, quindi priva di espedienti prospettici convenzionali, sia, verosimilmente comune a quella guccioniana.







Anche la scelta di particolari sfumature violacee contribuiscono ad agitare le superfici dal piano all’orizzonte, amplificando l’intensità luministica e la limpidezza atmosferica, così come le tonalità chiare fondono in un tutt’uno unitario gli elementi aerei, minerali e liquidi. Dunque un sicuro controllo della visione, pienamente posseduta, in quel processo di fusione retinica della materia. E a proposito del violetto, Monet scriverà: «Ho finalmente scoperto il vero colore dell’atmosfera: è il violetto, l’aria fresca è violetta. Fra tre anni tutti lavoreranno col violetto» (primi anni ’90 dell’Ottocento). Non è un caso che anche Guccione sia giunto, ottant’anni dopo, alle medesime conclusioni, riconoscendo al colore il valore dell’immateriale inconsistenza.

In Guccione l’impianto prospettico è affidato sovente a uno sviluppo longitudinale, avente la funzione di dilatare massimamente la spazialità oltre la sottile orizzontalità dello sfondo, geometricamente scisso in due sezioni speculari. Di rado, invece, ci si apre alla veduta a volo d’uccello, ove il punto di vista, particolarmente alto, riduce la porzione inconsistente del cielo e accentua, per effetto, quella della distesa acquatica.
 Come ebbi umilmente modo di scrivere in un precedente articolo dedicato al maestro, il tema del mare, presente nella produzione pittorica dell’artista sin dalla fine degli anni Sessanta, diventa paradigmatico, ovvero lirica contemplativa ed evocativa delle nude e modulate trasparenze di quelle che lo stesso maestro chiama “Linee del mare”, a metà fra il richiamo naturalistico e una griglia geometrica in funzione rigorosamente compositiva.
Come ebbi umilmente modo di scrivere in un precedente articolo dedicato al maestro, il tema del mare, presente nella produzione pittorica dell’artista sin dalla fine degli anni Sessanta, diventa paradigmatico, ovvero lirica contemplativa ed evocativa delle nude e modulate trasparenze di quelle che lo stesso maestro chiama “Linee del mare”, a metà fra il richiamo naturalistico e una griglia geometrica in funzione rigorosamente compositiva.

E se nel dettaglio si coglie verosimilmente la carne, è nella sintesi che si coglie intuitivamente l’anima, senza filtri codificati, piuttosto, nell’invulnerabilità della sua memoria nel suo continuo denudarsi. Ed è in questa calda sinfonia di luce, ove la risacca dorme al pari del suo placito orizzonte, che si plasma quel lirico amplesso tra Sampieri e Donnalucata: due borghi tufacei baciati dalla salsedine, la quale, generosa, depone sulla spiaggia e lungo i loro vicoli stretti il suo ‘seme’, sospinta da una leggere brezza come la Venere botticelliana dal soffio di Zefiro e Flora.

Quei muri bassi di tufo tirati su a secco delimitano la stretta via che dal litorale di Sampieri e Donnalucata conduce al “tempio” del pittore di Scicli sito in contrada Quartarella, a due passi dal centro di quella deliziosa cittadina tardo-barocca, che è Modica, e a circa 24 Km dalla costa, non sufficienti per offuscarne la visuale, per cancellarne la memoria. Dalla terrazza di Guccione il mare lo si vede ancora, eccome! Giù a valle, oltre quel tappeto variopinto di fichidindia e melograni, di ibischi e carrubi, dolcemente disteso a guisa di un drappo azzurro d’infinitesimi riflessi argentei su di un’epidermide levigata e trepida al sol tatto.

Quante volte, quante, nella brezza del mattino, quando i timidi raggi del primo sole accarezzano gli eleganti profili tardo-barocchi del paese sulla collina, o nell’afa del pomeriggio, quando ci si abbandona al “dolce far niente” all’ombra del refrigerio, ho sostato dinanzi la sua casa come un fedele dinanzi a un santuario. Quante volte! Attraversare per incanto le grigie pareti esterne e discretamente spiare il suo giorno tra quiete e meditazione, tra oli e pastelli, alla ricerca di un azzurro, sempre lo stesso e mai lo stesso.

E io quel drappo azzurro d’infinitesimi riflessi argentei, steso su quell’ultimo limitare, l’ho vissuto, respirato, toccato; ne ho assaporato il salmastro sapore sulle labbra, la cristallina leggerezza sul palmo della mano, il piacevole refrigerio sul colorito olivastro. Come me, come tutti coloro che hanno conosciuto quei luoghi, anche Guccione ha amato le passeggiate solitarie alle luci del primo mattino in quell’insenatura lunga 2 Km, che dalla spiaggetta di Sampieri conduce alla Fornace Penna di Capo Pisciotto, divenuta celebre come location del “Commissario Montalbano”.


Ciò al fine di fotografare con occhio esperto, qual è il suo, lo scenario dipanatosi in quello stadio così profondamente contemplativo. Eppure non è un’operazione en plein air la sua; non è il fissaggio di un attimo fugace, quanto, piuttosto, un’immagine generata in atelier attraverso il lento filtraggio della memoria, scremata da ogni residuo di asprezza e spigolosità.

Eppure non può esserci solo lirismo quando quello che fino a ieri era un paesaggio cristallino ora è brutalmente violato dalla presenza di piloni e tralicci, puntualmente rappresentati dal pittore in lavori come “Paesaggio a Punta Corvo” (1974-75), nel quale si può leggere il preambolo a ciò che di lì a poco si compirà tra abusivismo isterico e ostruzioni cementizie. Il mare è sempre quello, il contesto no! E lo si sa, al peggio non c’è mai fine quando l’uomo sa spingersi oltre l’autolesionismo più scellerato.
E quella fiabesca distesa azzurra sa tingersi, ahimè, anche plastica e catrame, imperdonabilmente depositati su quella stessa spiaggia dorata tra Sampieri e Donnalucata a fine estate, quale simbolo dello scempio perpetrato dall’incivile megalomania della razza umana… Ho detto umana?? Quello di “La fine dell’estate n. 2” (1987), “Paesaggio” (1994) e “Da Courbet, l’altra faccia del Mediterraneo” (2011) è un “mare nero” a cui il pittore dà forma fin dagli anni ’80 del Novecento come atto di accusa, di denuncia sociale all’ottusità senza ragione che divora vorace il perimetro intorno per alimentare il proprio ego.


Guccione denuncia sottilmente e sottilmente torna al mare, incantevole, depurato, sublimato: il suo! Perché se una speranza è ancora possibile, questa non può che annidarsi in ciò che fu e che si vuole sia nuovamente. E cos’é la speranza se non desiderio? Come insegna Aristotele: «l’agire moralmente buono è un fine, e il desiderio è desiderio di questo fine». (“Etica Nicomachea”, IV sec. a.C.).

Quindi un distaccarsi e allontanarsi fisico, mentale, ottico e sonoro dall’immensità dello scibile per un ritorno vertiginoso all’essenza stessa della visione strutturata, ove tutto acquista il sapore dell’evanescenza, dell’inafferrabile, vale a dire di senso del vuoto; quel vuoto insito nei due elementi complementari, mare e cielo fusi in un’osmosi indissolubile. E il Mediterraneo, con il suo corpo che cambia pelle al mutare del divenire, è sinonimo di questa evanescenza magistralmente simulata ed eternata da Guccione, quale testamento spirituale di una dedizione assoluta alla meraviglia del creato:
«È lo stupore, e uno sconfinato senso di meraviglia, di commozione per tanto e sublime ordine, oltre alla gratitudine verso la vita che ci offre questo alto e silenzioso spettacolo. Prima di finire, mi piacerebbe poter dire tutto questo con la pittura, più compiutamente di quanto abbia fatto fino a oggi, almeno tentato».

Piero Guccione, bontà sua, forse non saprà mai di aver già detto tutto, ma proprio tutto, e compiutamente con la sincerità assorta del suo sguardo. Lui persevera nella missione con i mezzi che gli sono propri al fine di tradurre in immagini ciò che nell’idea nasce in astratto. Lo fa con occhio e pennello, non è una novità, e «tutta l’esperienza del vissuto sembra cancellarsi, mentre quella del lavoro è quasi percepibile unicamente collocata tra il pollice, l’indice e il medio della mano destra: vale a dire sull’alveo corporale dove il pennello si posa». E ciò per il fine ultimo di «rivelare la visibilità delle cose e il loro enigma. Che, in Sicilia, vuol dire soprattutto la visibilità inafferrabile della luce: ogni giorno più splendente di meraviglie come mai viste prima». (Piero Guccione, “Tra il pollice, l’indice e il medio della mano destra”, 2015)
N.B. Vi diamo appuntamento alla parte seconda del nostro viaggio, interamente dedicata alle marine di Giovanni Iudice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA